La chiesa di San Francesco
a Borgo San Lorenzo
Borgo
San Lorenzo e la sua cittadinanza stanno per riacquistare la possibilità di
godere di uno straordinario tesoro di arte e di storia, che per troppi anni
era rimasto nascosto e semisconosciuto: è infatti quasi ultimato il
restauro della chiesa di San Francesco, che sorge assieme
all'antico complesso conventuale accanto al Santuario del SS. Crocifisso,
all'inizio di via Pietro Caiani. Il restauro, condotto con estrema
attenzione e con rigoroso scrupolo filologico dall’architetto Mario Salmi
(in accordo con la Soprintendenza fiorentina ai Beni Architettonici), ha
ricondotto alle antiche linee il vasto ambiente della chiesa ed ha permesso
anche di portare alla luce o recuperare preziose testimonianze d'arte.
Questo restauro, che giunge quanto mai opportuno, si riallaccia a quello
iniziato verso la fine dei secondo conflitto mondiale e che aveva sistemato
la copertura ed il paramento murario danneggiato, riaperto alcune finestre
ed altri interventi ancora. Se a questo si unisce il desiderio dei
proprietari di consentire il pubblico godimento della chiesa,
preferibilmente destinandola al suo originario utilizzo come luogo di culto,
si capisce come l'iniziativa sia preziosa, gradita, altamente significativa
e meritevole di essere portata all'attenzione della pubblica opinione.
l'auspicio è che sia possibile, malgrado le difficoltà, condurre a termine i
lavori nelle parti che ancora li necessitano per poter ripristinare
completamente la chiesa ed i suoi annessi.
Il convento di San Francesco fu fondato, secondo la tradizione,
dagli Ubaldini da Ripa a testimonianza della loro devozione nei
confronti dei Santo assisiate, quando ancora egli era vivente (morì nel
1226). Dai primi seguaci del santo fu all'inizio ampliata e riadattata una
preesistente chiesa dedicata a sant'Andrea. Successivamente, nel corso dei
XIII secolo la comunità religiosa fu oggetto di numerosi lasciti e
donazioni, fra le quali una di Folco Portinari, padre della Beatrice
dantesca, risalente al 1287, circostanza che certamente consentì alla sempre
più numerosa comunità religiosa di iniziare la costruzione di una più grande
chiesa, quella attuale che dovrebbe risalire alla seconda metà del XIII
secolo. Nel corso dei secoli il convento, aderente all'Ordine dei Frati
Minori conventuali (gli stessi della basilica fiorentina di Santa Croce
e di quella di San Francesco ad Assisi), si ingrandì e nel Cinquecento fu
restaurato da un maestro Alessandro Ferrini. La vita religiosa ebbe
fine nel 1808, quando il convento fu soppresso dal governo napoleonico, i
frati furono allontanati e l'intero complesso, quasi completamente spogliato
dei suoi beni, divenne di proprietà privata. La vasta chiesa presenta una
facciata a capanna
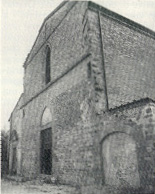 edificata
in piccole bozze di pietra di cava, già accuratamente pulite nel corso dei
restauro. Sopra l'ingresso si trova una lunetta ogivale sormontata da
una grande monofora archiacuta. Di notevole interesse è l'antica porta
trecentesca, in solido legno di quercia, anch'essa molto ben restaurata
e sottratta alla rovina dei secoli. Sulla sinistra si vede la piccola ed
elegante facciata della cappella seicentesca
dedicata a San Sebastiano, forse in origine sede di una confraternita
laicale ed al cui interno è conservato l'originale altare in stucco
policromo. All'interno (vedi foto sotto il titolo) il colpo d'occhio della
grande navata della chiesa è veramente spettacolare: siamo in
presenza di una autentica e preziosa aula predicatoria francescana, con
copertura a campate lignee, costruita interamente in laterizio, che
conferisce all'intero ambiente un caldo colore rosaceo. L'edificio, in tutta
evidenza, ripete l'illustre modello della basilica superiore di San
Francesco ad Assisi, anche se nel nostro caso, in omaggio ad una pressoché
costante tradizione toscana, si rinuncia all'impiego delle grandi volte a
crociera in favore della copertura a campate lignee, di più facile e sicura
realizzazione. Il vasto e luminoso spazio unitario dell'aula predicatoria
converge verso la graziosa scarsella della parete di fondo, sulla cui parete
terminale si apre una snella bifora ogivale, in parte risalente ad un
restauro precedente, ma molto probabilmente sulla base di strutture antiche.
edificata
in piccole bozze di pietra di cava, già accuratamente pulite nel corso dei
restauro. Sopra l'ingresso si trova una lunetta ogivale sormontata da
una grande monofora archiacuta. Di notevole interesse è l'antica porta
trecentesca, in solido legno di quercia, anch'essa molto ben restaurata
e sottratta alla rovina dei secoli. Sulla sinistra si vede la piccola ed
elegante facciata della cappella seicentesca
dedicata a San Sebastiano, forse in origine sede di una confraternita
laicale ed al cui interno è conservato l'originale altare in stucco
policromo. All'interno (vedi foto sotto il titolo) il colpo d'occhio della
grande navata della chiesa è veramente spettacolare: siamo in
presenza di una autentica e preziosa aula predicatoria francescana, con
copertura a campate lignee, costruita interamente in laterizio, che
conferisce all'intero ambiente un caldo colore rosaceo. L'edificio, in tutta
evidenza, ripete l'illustre modello della basilica superiore di San
Francesco ad Assisi, anche se nel nostro caso, in omaggio ad una pressoché
costante tradizione toscana, si rinuncia all'impiego delle grandi volte a
crociera in favore della copertura a campate lignee, di più facile e sicura
realizzazione. Il vasto e luminoso spazio unitario dell'aula predicatoria
converge verso la graziosa scarsella della parete di fondo, sulla cui parete
terminale si apre una snella bifora ogivale, in parte risalente ad un
restauro precedente, ma molto probabilmente sulla base di strutture antiche.
 La
volta a crociera con quattro vele costolonate è stata ricostruita in
occasione del presente restauro, utilizzando i componenti polilobati
originali recuperati ed evidenziando opportunamente le parti reintegrate con
l'impiego dell'intonaco. Sulle pareti laterali si aprono alte
monofore ogivali restaurate (quelle del lato sinistro sono state
parzialmente tamponate per la successiva realizzazione di strutture
esterne). Sul lato destro si trova, molto ben conservato e restaurato, il
Casamento del pulpito, costituito da un grande peduccio in pietra serena
scolpita che, con la veramente bella decorazione a cesto, richiama
esempi di capitelli fiorentini della seconda metà del Quattrocento. Poco
oltre si trova la grande porta (attualmente tamponata) che collegava
la chiesa col chiostro del convento e che mostra uno splendido arco in
laterizio. In prossimità dell'ingresso principale si trovano i resti,
altamente significativi, di quella che doveva essere l'originaria
decorazione pittorica delle pareti, secondo una consuetudine comune alle
più importanti chiese francescane: sulla parete sinistra si trova la
raffigurazione ad affresco di una "Madonna coi Bambino tra angeli
ed i santi Antonio da Padova e Ludovico di Tolosa" (la parte destra dei
dipinto, ove dovevano trovarsi altri due santi è andata perduta). Ai piedi
del trono, inginocchiate, si vedono due figure elegantemente vestite in
abiti trecenteschi, identificabili nei donatori dell'affresco. L'opera è
tradizionalmente attribuita al pittore mugellano Pietro Nelli da Rabatta
(attivo dal 1375 al 1419, anno della morte), artista orbitante intorno
all'ambiente di Niccolò di Pietro Cerini, uno dei più importanti e prolifici
pittori fiorentini della fine del Trecento. Secondo il Niccolai (1914) il
dipinto recava la firma del Nelli e la data 1382, probabilmente
riconoscibili nella scritta presente sul gradino del trono e che deve essere
tornata alla luce in occasione del restauro se il Boskovits (Boskovits M.,
Pittura fiorentina alla vigilia dei Rinascimento, Firenze, 1975, p. 416)
attribuisce l'opera a Pietro di Miniato, un altro pittore fiorentino
di quegli stessi anni, e dice che l'iscrizione risultava non più presente.
Sulla sinistra si vedono ancora i resti di un secondo affresco,
sempre dello stesso pittore, che doveva raffigurare una santa seduta sul
trono e dei quale rimangono in basso due piccole scene di martirio ad
uso di predella. Questi dipinti, ormai irrimediabilmente danneggiati dal
tempo, e gli altri presenti nella chiesa, sono stati accuratamente
restaurati nel corso di questa campagna di lavori. Sul lato sinistro della
controfacciata è tornato alla luce un affresco, seriamente
danneggiato dalla sovrapposizione di un altare nel XVIII secolo,
raffigurante la "Deposizione di Cristo nel sepolcro" scena della
quale si è salvata solo la parte inferiore. Magnificamente restaurata, la
pittura, evidentemente protetta nelle parti superstiti da una scialbatura e
dall'altare sovrapposto, ha conservato la sua splendida e smagliante
policromia. L'opera, che attende e che merita uno studio approfondito, si
mostra di una notevole qualità artistica, evidente nella padronanza spaziale
della realizzazione del sepolcro di scorcio e nella plastica definizione dei
volumi, oltre che nella già ricordata bellezza della gamma cromatica. Si
tratta certamente del lavoro di un Maestro fiorentino del XIV secolo
di primaria importanza. La parete destra ospita, invece, un grande
affresco tardocinquecentesco raffigurante probabilmente il "Martirio
degli undicimila martiri".
La
volta a crociera con quattro vele costolonate è stata ricostruita in
occasione del presente restauro, utilizzando i componenti polilobati
originali recuperati ed evidenziando opportunamente le parti reintegrate con
l'impiego dell'intonaco. Sulle pareti laterali si aprono alte
monofore ogivali restaurate (quelle del lato sinistro sono state
parzialmente tamponate per la successiva realizzazione di strutture
esterne). Sul lato destro si trova, molto ben conservato e restaurato, il
Casamento del pulpito, costituito da un grande peduccio in pietra serena
scolpita che, con la veramente bella decorazione a cesto, richiama
esempi di capitelli fiorentini della seconda metà del Quattrocento. Poco
oltre si trova la grande porta (attualmente tamponata) che collegava
la chiesa col chiostro del convento e che mostra uno splendido arco in
laterizio. In prossimità dell'ingresso principale si trovano i resti,
altamente significativi, di quella che doveva essere l'originaria
decorazione pittorica delle pareti, secondo una consuetudine comune alle
più importanti chiese francescane: sulla parete sinistra si trova la
raffigurazione ad affresco di una "Madonna coi Bambino tra angeli
ed i santi Antonio da Padova e Ludovico di Tolosa" (la parte destra dei
dipinto, ove dovevano trovarsi altri due santi è andata perduta). Ai piedi
del trono, inginocchiate, si vedono due figure elegantemente vestite in
abiti trecenteschi, identificabili nei donatori dell'affresco. L'opera è
tradizionalmente attribuita al pittore mugellano Pietro Nelli da Rabatta
(attivo dal 1375 al 1419, anno della morte), artista orbitante intorno
all'ambiente di Niccolò di Pietro Cerini, uno dei più importanti e prolifici
pittori fiorentini della fine del Trecento. Secondo il Niccolai (1914) il
dipinto recava la firma del Nelli e la data 1382, probabilmente
riconoscibili nella scritta presente sul gradino del trono e che deve essere
tornata alla luce in occasione del restauro se il Boskovits (Boskovits M.,
Pittura fiorentina alla vigilia dei Rinascimento, Firenze, 1975, p. 416)
attribuisce l'opera a Pietro di Miniato, un altro pittore fiorentino
di quegli stessi anni, e dice che l'iscrizione risultava non più presente.
Sulla sinistra si vedono ancora i resti di un secondo affresco,
sempre dello stesso pittore, che doveva raffigurare una santa seduta sul
trono e dei quale rimangono in basso due piccole scene di martirio ad
uso di predella. Questi dipinti, ormai irrimediabilmente danneggiati dal
tempo, e gli altri presenti nella chiesa, sono stati accuratamente
restaurati nel corso di questa campagna di lavori. Sul lato sinistro della
controfacciata è tornato alla luce un affresco, seriamente
danneggiato dalla sovrapposizione di un altare nel XVIII secolo,
raffigurante la "Deposizione di Cristo nel sepolcro" scena della
quale si è salvata solo la parte inferiore. Magnificamente restaurata, la
pittura, evidentemente protetta nelle parti superstiti da una scialbatura e
dall'altare sovrapposto, ha conservato la sua splendida e smagliante
policromia. L'opera, che attende e che merita uno studio approfondito, si
mostra di una notevole qualità artistica, evidente nella padronanza spaziale
della realizzazione del sepolcro di scorcio e nella plastica definizione dei
volumi, oltre che nella già ricordata bellezza della gamma cromatica. Si
tratta certamente del lavoro di un Maestro fiorentino del XIV secolo
di primaria importanza. La parete destra ospita, invece, un grande
affresco tardocinquecentesco raffigurante probabilmente il "Martirio
degli undicimila martiri".
 Si
tratta di una complessa ed articolata scena, inquadrata architettonicamente
da due grandi colonne dipinte, con un gran numero di figure, fra le quali
campeggiano, in basso a sinistra l'imperatore Diocleziano nell'atto di
giudicare uno dei martiri ancora rivestito della corazza, al centro una
grande figura maschile crocifissa, mentre in alto appare il Cristo
benedicente. L'intera scena ha ormai perduto il rigoroso rispetto delle
proporzioni e della spazialità. Studi in corso da tempo (Chiarelli)
sembravano indirizzarsi verso l'attribuzione dell'opera ad un pittore
veronese, anche se forse, il riferimento ad un fiorentino, di quelli
afferenti al gruppo dei cosiddetti "eccentrici", per la tendenza allo stile
esasperato ed intellettualistico, non sarà ancora da scartarsi
completamente. Interessante risulterà anche la identificazione dello stemma,
probabilmente gentilizio o appartenente ad una Confraternita del paese,
dipinto in basso a destra, e comunque riferibile ai committenti dell'opera.
Sul pavimento, ancora privo del rivestimento in cotto, di prossima
messa in opera, si trovano due sepolture, la, più significativa delle
quali, posta al centro della navata, di fronte ai gradini di accesso al
grande presbiterio, è costituita da una interessante lastra tombale
gentilizia con iscrizione in caratteri gotici e databile al XV secolo
(anch'essa appena restaurata e risistemata nella sua antica collocazione).
Sulla parete sinistra si vede l'arco di accesso alla già ricordata cappella
di San Sebastiano, accanto al quale si trova l'ingresso ad una seconda
cappella, che rappresenta certamente un'altra delle piacevoli scoperte
di questo restauro e alla quale, data la sua importanza, si dedicherà un
articolo apposito sul prossimo numero. Di fianco alla scarsella terminale,
attualmente non interessata ai lavori di restauro, sorge anche un
ambiente a pianta quadrata, anch'esso risalente all'epoca gotica e
dotato di una grande mostra d'altare rinascimentale in pietra.
Si
tratta di una complessa ed articolata scena, inquadrata architettonicamente
da due grandi colonne dipinte, con un gran numero di figure, fra le quali
campeggiano, in basso a sinistra l'imperatore Diocleziano nell'atto di
giudicare uno dei martiri ancora rivestito della corazza, al centro una
grande figura maschile crocifissa, mentre in alto appare il Cristo
benedicente. L'intera scena ha ormai perduto il rigoroso rispetto delle
proporzioni e della spazialità. Studi in corso da tempo (Chiarelli)
sembravano indirizzarsi verso l'attribuzione dell'opera ad un pittore
veronese, anche se forse, il riferimento ad un fiorentino, di quelli
afferenti al gruppo dei cosiddetti "eccentrici", per la tendenza allo stile
esasperato ed intellettualistico, non sarà ancora da scartarsi
completamente. Interessante risulterà anche la identificazione dello stemma,
probabilmente gentilizio o appartenente ad una Confraternita del paese,
dipinto in basso a destra, e comunque riferibile ai committenti dell'opera.
Sul pavimento, ancora privo del rivestimento in cotto, di prossima
messa in opera, si trovano due sepolture, la, più significativa delle
quali, posta al centro della navata, di fronte ai gradini di accesso al
grande presbiterio, è costituita da una interessante lastra tombale
gentilizia con iscrizione in caratteri gotici e databile al XV secolo
(anch'essa appena restaurata e risistemata nella sua antica collocazione).
Sulla parete sinistra si vede l'arco di accesso alla già ricordata cappella
di San Sebastiano, accanto al quale si trova l'ingresso ad una seconda
cappella, che rappresenta certamente un'altra delle piacevoli scoperte
di questo restauro e alla quale, data la sua importanza, si dedicherà un
articolo apposito sul prossimo numero. Di fianco alla scarsella terminale,
attualmente non interessata ai lavori di restauro, sorge anche un
ambiente a pianta quadrata, anch'esso risalente all'epoca gotica e
dotato di una grande mostra d'altare rinascimentale in pietra.
Al termine della visita alla chiesa francescana si deve
fare un rapido accenno al patrimonio artistico che pos- sedeva e che è
andato disperso nel corso dei secoli. Oltre alle notizie secondo le quali
nella chiesa, un tempo ricca di altari e cappelle gentilizie, si trovavano
opere di Andrea del Sarto e di Francesco Furini si deve ricordare la recente
identificazione (Acidini, 1990) della grande paia d'altare raffigurante "San
Francesco che riceve le Stimmate", un tempo sull'altare maggiore della
chiesa, col dipinto conservato al Fogg Museum di Cambridge (Massachussets,
U.S.A.), recentemente attribuito a Taddeo Gaddi, il più illustre allievo di
Giotto. Un ulteriore elemento è costituito dalla presenza di un numero
consistente di stemmi, alcuni dotati di notevole qualità artistica, il cui
studio darà un contributo fondamentale alla ricostruzione di un tessuto
storico locale, altrimenti destinato al l'oblio. Usciti dalla chiesa sarà
opportuno segnalare, sul fianco destro, la presenza dell'antico portale
d'ingresso al convento, purtroppo unico resto della grande recinzione
sulla quale si appoggiava il lato occidentale del chiostro (ora
completamente scomparso), dei quale rimane solo il perimetro, al cui centro
si trova una vera da pozzo poligonale ottocentesca.
 Rimane,
però, l'ingresso a quella che doveva essere la sala capitolare dei convento,
composto da due splendide bifore con rosone polilobato e da una
grande monofora centrale. I capitelli dei sostegni sono splendidamente
scolpiti con motivi vegetali del più puro ed elegante gusto gotico, altro
autentico gioiello di. questo complesso ricolmo di arte e di storia e che è
stato sottratto alla rovina grazie all'impegno dei proprietari, ai quali
deve essere dato il sostegno necessario per condurre a termine i lavori e
per consentire la riapertura al pubblico di questo monumento mugellano.
Rimane,
però, l'ingresso a quella che doveva essere la sala capitolare dei convento,
composto da due splendide bifore con rosone polilobato e da una
grande monofora centrale. I capitelli dei sostegni sono splendidamente
scolpiti con motivi vegetali del più puro ed elegante gusto gotico, altro
autentico gioiello di. questo complesso ricolmo di arte e di storia e che è
stato sottratto alla rovina grazie all'impegno dei proprietari, ai quali
deve essere dato il sostegno necessario per condurre a termine i lavori e
per consentire la riapertura al pubblico di questo monumento mugellano.
Marco Pinelli